

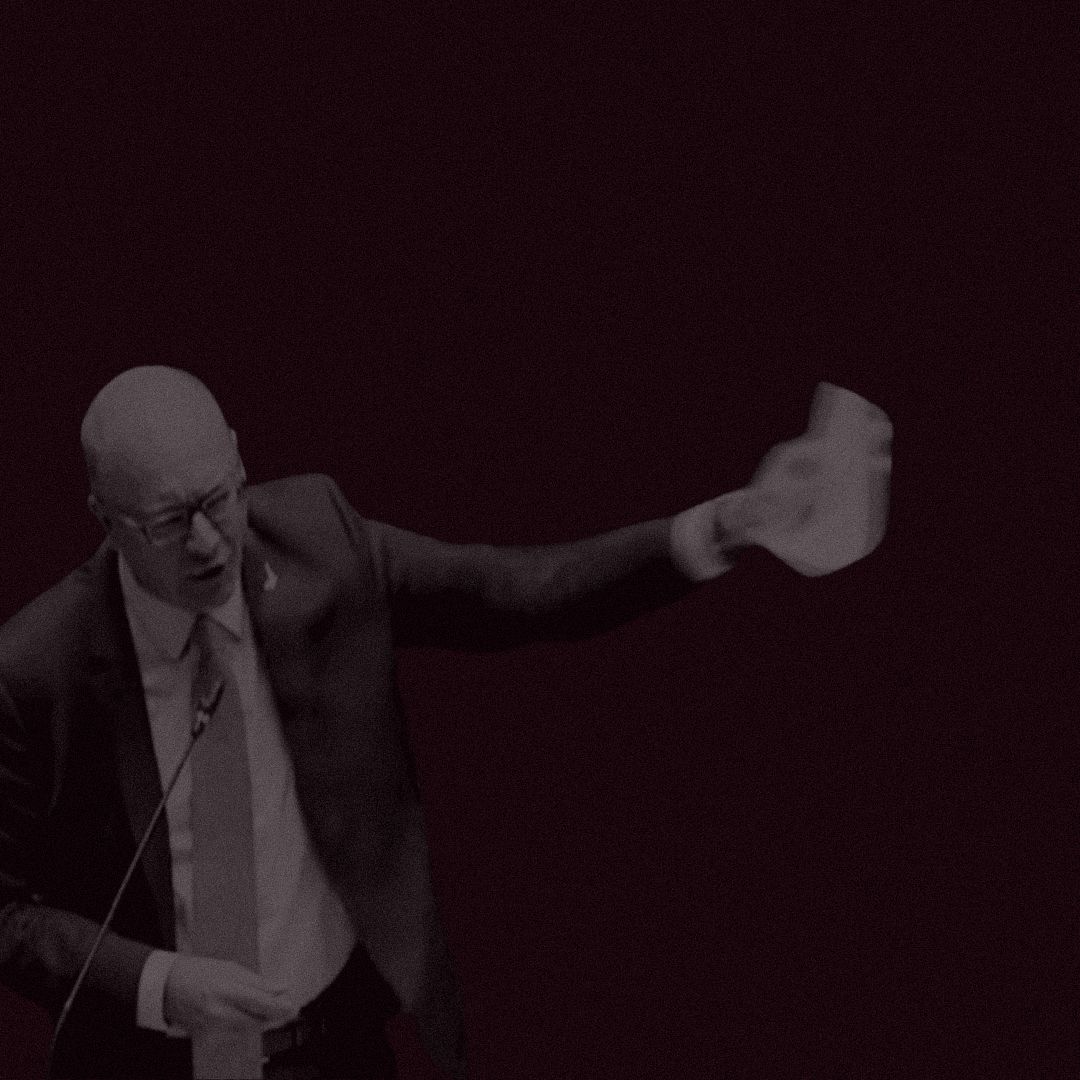
Il 14 ottobre 2025 Gianluca Soncin uccideva la sua ex compagna Pamela Genini, mentre lei telefonava a un altro ex chiedendo aiuto per far intervenire la polizia. Nello stesso momento, la commissione Cultura della Camera approvava un emendamento che vieta l’educazione sessuo-affettiva anche nelle scuole medie.1 Si tratta di una sincronia rivelatrice, che mostra non solo la persistenza di una cultura patriarcale, ma anche una logica politica precisa. Intervenire a violenza ultimata, quando la vita è già stata tolta; investire risorse nel sistema penale – più polizia, più carcere, pene più severe – ma quasi nulla nella formazione culturale che potrebbe prevenirla. In questo gesto di omissione c’è un potere che decide quali vite meritano protezione e quali possono essere abbandonate alla violenza; significa, nella pratica, che lo Stato lascia morire le donne.
Questo meccanismo non è nuovo. La sovranità moderna non si esercita solo nel “far vivere”, ma anche nel “lasciare morire”. Mbembe, riprendendo e radicalizzando questa idea, la chiama necropolitica: una forma di governo che seleziona le esistenze degne di tutela e quelle sacrificabili, esponendole alla morte per indifferenza.2 Quando lo Stato taglia i fondi ai centri antiviolenza e blocca l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva obbligatoria nelle scuole, sta praticando quella stessa necropolitica. In questo senso, l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole è uno degli strumenti più efficaci per decostruire gli stereotipi di genere e i modelli di mascolinità tossica che alimentano la violenza, come da anni sottolineano i movimenti femministi e transfemministi italiani.3 Eppure, mentre si moltiplicano femminicidi, trans*cidi e lesbicidi, il governo sceglie di impedirne la diffusione.4
La storia di Pamela segue un copione che conosciamo troppo bene: controllo coercitivo, stalking, minacce di morte. Per oltre un anno aveva subito terrorismo intimo, un sistema di dominio fatto di sorveglianza, isolamento, intimidazione, violenze fisiche. Pamela non aveva mai denunciato, come la stragrande maggioranza delle donne che subisce violenza domestica, scoraggiate da un sistema che troppo spesso non le protegge. Eppure, dopo un’aggressione nel 2024, aveva dichiarato in ospedale che temeva per la sua vita: nessun protocollo era comunque partito per tutelarla. Nel frattempo, stava cercando di allontanarsi, come hanno raccontato le persone a lei vicine.
Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Nazionale Femminicidi, Lesbicidi e Trans*cidi di Non Una di Meno, nei primi dieci mesi del 2025 almeno 70 donne sono state uccise da partner o ex partner. Di fronte a questi numeri in crescita, la risposta del governo resta centrata sul sistema penale: più arresti, condanne e carcere, senza intervenire sulle cause culturali e strutturali della violenza.
Il Codice Rosso, approvato nel 2019, ha introdotto procedure accelerate per i reati di violenza domestica e di genere: denunce prioritarie, ascolto protetto delle vittime e tempi più brevi per indagini e processi. Tuttavia, come mostrano i dati,5 queste misure repressive non riescono a raggiungere le donne che non denunciano o a prevenire i femminicidi prima che accadano. Il nostro apparato di tutela funziona solo a posteriori: dopo la denuncia, dopo le prove, spesso dopo la morte. È una logica puramente reattiva e penalistica.
Manca un investimento nelle condizioni materiali e culturali, che renderebbero possibile prevenire la violenza: case rifugio, sportelli di ascolto, supporto legale e psicologico, centri antiviolenza adeguatamente finanziati,6 reti di protezione che colleghino scuole, servizi sociali, ospedali e forze dell’ordine. Manca una formazione diffusa che insegni a riconoscere il controllo coercitivo come abuso e non come questione privata. E manca un’educazione che, fin dall’adolescenza, decostruisca gli stereotipi di genere e le relazioni basate sul possesso, evitando che norme e comportamenti abusanti si radichino come “normalità”.
Il disegno di legge Valditara parte da un presupposto ideologico chiaro: l’educazione sessuo-affettiva è ‘‘propaganda ideologica LGBT’’, una minaccia ai ‘‘valori tradizionali della famiglia’’. Con il nuovo emendamento approvato dalla maggioranza questo divieto si estende fino alle scuole medie. In pratica, l3 ragazz3 vengono lasciat3 senza strumenti proprio quando sperimentano le prime relazioni affettive e sessuali e rischiano di interiorizzare gli stereotipi di genere più pericolosi: non potranno accedere ad alcun progetto di educazione all’affettività, alla sessualità consapevole, al consenso, alla prevenzione delle IST, al rispetto nelle relazioni.
Alle superiori, l’educazione sessuo-affettiva sarà teoricamente possibile, ma solo con il consenso scritto dei genitori, che dovranno approvare contenuti, materiali e competenze delle persone formatrici. Chi rifiuterà dovrà proporre delle ‘‘attività alternative’’. In un sistema scolastico già al collasso, con 250.000 docenti precari e strutture inadeguate, si aggiunge un ulteriore carico burocratico che renderà di fatto impraticabile qualsiasi iniziativa. Il provvedimento non si limita a questo. Vieta il coinvolgimento di figure esterne – associazioni, ONG, operator3 sanitari – che fino ad oggi hanno supplito all’assenza di programmi ufficiali di educazione sessuale nelle scuole italiane. Dal momento che l’educazione affettiva non è mai stata inserita nei programmi curricolari, eliminare la possibilità di interventi esterni significa semplicemente cancellarla del tutto.
Dietro questa scelta c’è il lavorio sistematico delle lobby ultraconservatrici. Pro Vita & Famiglia ha celebrato l’approvazione del DDL Valditara come “una giornata storica”, rivendicando il proprio ruolo di pressione sul governo. A marzo 2025 l’associazione aveva lanciato la campagna “Mio figlio no”, dipingendo questi progetti educativi come imposizioni ideologiche pericolose per i minori. Pochi giorni dopo, Valditara incontrava i rappresentanti di Pro Vita. Il risultato è sotto i nostri occhi.
Queste mobilitazioni non sono episodi isolati, ma parte di una strategia politico-culturale che mira a ridefinire lo spazio pubblico e le politiche educative secondo un’«ipotesi neocattolica».7 In questa visione, associazioni quali Pro Vita operano come veri e propri attori politici capaci di orientare l’agenda legislativa, non tanto per motivi religiosi in senso stretto, quanto per riaffermare un modello di società fondato su un ordine naturale eterosessuale e binario. È una crociata anti-gender, dove il termine “gender” diventa nemico simbolico e catalizzatore di paure, utile a costruire un fronte reazionario transnazionale. Le loro campagne mobilitano genitori, elettori e istituzioni contro qualsiasi apertura verso la pluralità di genere e orientamento sessuale, invocando la cosiddetta “libertà educativa”.
In realtà, tali azioni hanno l’effetto diretto di colpire e marginalizzare le nostre comunità, in particolare l3 giovan3 queer che vivono identità non conformi nelle scuole, così come insegnanti e educatori impegnati in percorsi di educazione alle differenze. In nome della “protezione dei figli”, si restringono in realtà gli spazi di libertà, visibilità e dignità per intere categorie sociali, rendendole nuovamente vulnerabili alla discriminazione istituzionale e sociale.
I movimenti lo ripetono da tempo: la violenza maschile contro le donne e le soggettività LGBTQ+ non è un’emergenza, ma una componente strutturale del patriarcato. Per questo l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole non è una misura accessoria, ma una rivendicazione politica fondamentale. L’educazione che chiediamo è transfemminista e queer: mette in discussione i ruoli di genere imposti e binari, i dispositivi del dominio maschile e l’eterosessualità obbligatoria. La pedagogia dell’affettività non serve soltanto a prevenire la violenza o promuovere la salute: è una pratica di liberazione collettiva. Insegna a decostruire l’idea di famiglia come unica cellula sociale, a rifiutare la logica del possesso nelle relazioni, ad affermare il diritto all’autodeterminazione dei corpi e dei desideri. È questo che la rende così minacciosa per chi vuole imporre un solo modello di vita e di relazione.
Il rifiuto della destra di affrontare la violenza come fenomeno strutturale, e non come somma di casi isolati, è parte integrante del problema. Continuano a descriverla come devianza o follia individuale, negando che affondi le radici nei rapporti di potere e nelle gerarchie che attraversano scuola, famiglia e istituzioni.
Il paradosso è evidente. Il governo Meloni firma protocolli con la Fondazione dedicata a Giulia Cecchettin, ma contemporaneamente smantella gli strumenti di prevenzione reale. È più semplice promettere pene severe che investire nella formazione a lungo termine. È più conveniente, per una destra che ha fatto dei “valori tradizionali” il suo cavallo di battaglia, evitare qualsiasi discorso che metta in discussione i ruoli di genere. In questo senso, il diritto penale offre risposte immediate, visibili, emotive. Ma a che prezzo?
Il prezzo è l’adesione, spesso inconsapevole, a una pulsione punitiva che affida la protezione delle donne e delle persone queer alla macchina repressiva dello Stato, rafforzando proprio quelle logiche di controllo e punizione da cui il femminismo spesso cerca di liberarsi. Come sostiene Verdolini, il rischio è di chiedere allo strumento penale di risolvere problemi di ordine culturale.8 La prevenzione culturale richiede tempo, costanza e la capacità di sradicare il problema alla radice. Quando chiediamo al sistema penale di educare una società, ne confondiamo la funzione. Delegare ai tribunali il compito di abbattere la violenza di genere significa affidare a un’istituzione giuridica quello che dovrebbe essere un progetto politico-culturale collettivo.
I femminicidi, i trans*cidi e i lesbicidi non sono inevitabili: nascono da una cultura e da rapporti di potere che si possono trasformare. Per farlo, è necessario riconoscere che educare è un atto politico. La libertà dalla violenza e la tutela da essa non si garantiscono inasprendo le pene, ma costruendo una società più giusta, consapevole e libera. Per Pamela e per tutt3 non basta punire il singolo femminicida a fatto compiuto: bisogna impedire che la violenza accada ancora. Servono spazi di autonomia materiale e culturale. Serve, insomma, proprio quello che il governo ha deciso di vietare: l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole.
1 L’emendamento ha superato la Commissione Cultura, ma deve ancora essere approvato dall’aula della Camera e poi dal Senato prima di diventare legge definitiva.
2 A. Mbembe, Necropolitics, in «Public Culture», vol. 15, n. 1, 2003, pp.11-40.
3 Per esempio: https://nonunadimeno.wordpress.com/2017/11/21/sintesi-del-piano-femminista-contro-la-violenza-maschile-sulle-donne-e-tutte-le-forme-di-violenza-di-genere/.
4 In Italia l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole non è obbligatoria e la sua diffusione varia da istituto a istituto. I percorsi sono guidati dall3 insegnanti, spesso con il supporto di espert3 esterni (come quell3 della rete Educare alle Differenze, che raggruppa decine di associazioni attive sul tema).
5 https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-1-2025-i-primi-effetti-del-codice-rosso-sulla-repressione-penale-della-violenza-domestica-uno-sguardo-alla-giurisprudenza-in-materia-di-maltrattamenti-contro-familiari-e-conviventi-art-572-cp.
6 I centri anti-violenza in Italia sono storicamente sottofinanziati e spesso dipendono da fondi regionali, comunali o da progetti temporanei. Gran parte dei centri è gestita da associazioni, con integrazione di fondi propri, e la disponibilità dei servizi varia molto sul territorio.
7 S.Garbagnoli, M. Prearo, La crociata “anti-gender”: dal Vaticano alle manifpour tous, Kaplan, Torino 2018.
8 https://lucysullacultura.com/le-motivazioni-della-sentenza-turetta-e-il-femminismo-punitivo/.
Tutto il materiale originale pubblicato sul sito di QU’OUÏR, a meno di esplicita indicazione contraria in calce ai singoli lavori, è reso disponibile secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. (CC BY-NC-ND 4.0). Questo significa che chiunque ha l’autorizzazione per copiarlo, incollarlo, ripubblicarlo, condividerlo, distribuirlo e riprodurlo con ogni mezzo, purché non per scopi commerciali e senza apportare modifiche, a condizione di attribuirne esplicitamente l’appartenenza alla persona artefice del contributo e di citarne la provenienza (se possibile con un link al sito di QU’OUÏR).